Si compiono quest’anno i 150 anni dell’emigrazione italiana negli Stati meridionali del Brasile: mostre, esposizioni, conferenze, feste celebrano questa prima grande emigrazione di massa che si ritiene in un quarto di secolo abbia portato al di là dell’oceano oltre un milione di italiani. Siamo negli anni successivi all’unificazione dell’Italia che, è risaputo, non ha portato immediato beneficio alle zone periferiche come la nostra provincia, dalla quale si ritiene siano partire circa dodicimila persone. Ma a quando facciamo risalire i primi movimenti locali per il Sud America?
La prima testimonianza certa di emigrazione per il Brasile dal Bellunese ci viene fornita da un registro stilato dal parroco di Arsié che annotò la partenza degli emigranti della sua parrocchia: scopriamo così che il 22 novembre 1875 sei famiglie scelsero di lasciare definitivamente il loro paese dopo aver venduto il poco che avevano. I loro cognomi erano Brustolin, Bassani, Monesel e Sartor: in tutto ventisei persone, tra le quali anche due bambine di soli quattro anni. La loro destinazione finale fu lo Stato del Paranà, dove arrivarono nel marzo 1876. Da allora le partenze dai nostri paesi furono costanti e numericamente consistenti: ogni mese dell’anno era buono per raggiungere l’agognato paese che avrebbe dato loro, finalmente, un terreno proprio dove costruire la propria casa e coltivare i prodotti per il proprio sostentamento.
I bellunesi approdarono un po’ in tutti gli stati meridionali del Brasile: nel Rio Grande do Sul molti feltrini si insediarono nelle nascenti colonie di Caxias, Dona Isabel, Conde d’Eu e la Quarta Colônia; più tardi sorsero le colonie di Alfredo Chaves, São Marcos, Antônio Prado e Guaporé. Nello Stato di Santa Catarina arrivarono molti agordini e longaronesi per fondare le colonie di Blumenau, Brusque, Luís Alves, Urussanga, Nova Veneza e, guarda caso, Nova Belluno. Un buon numero di bellunesi arrivò anche in Paranà, in particolare intorno alla capitale Curitiba, e nello Stato di Espírito Santo, con riferimento soprattutto alla Colônia Demetrio Ribeiro. Qualcuno si fermò anche nello Stato di San Paolo per lavorare nelle fazendas di caffè.
Quasi tutto il Bellunese fu interessato da questa emigrazione: dal Feltrino emigrarono in massa da Arsié, Fonzaso, Seren del Grappa, ma anche da Lamon, Sovramonte, Cesiomaggiore, Santa Giustina, San Gregorio; Feltre stessa vide partire circa 500 persone, per lo più dalle frazioni. Dal Bellunese furono in molti a lasciare i paesi di Mel, Lentiai, Trichiana, Limana, Sospirolo, Sedico, Longarone e Soverzene. Tutta la Val di Zoldo conobbe questo fenomeno, come anche l’Agordino ed in particolare Agordo, La Valle e tutta la Val del Biois.
La traversata oceanica durava in media tre settimane ed era abbastanza impegnativa specialmente per bambini ed anziani, ma pure il trasferimento ai porti di imbarco non era facile: dai paesi partivano a piedi e con i carri portando con sé i bauli con le loro cose fino alla prima stazione del treno disponibile in quel momento. Uomini e donne che decidevano di partire si facevano coraggio l’un l’altro, per cui solitamente le partenze erano “in gruppo”, oppure erano interi gruppi famigliari a decidere di andarsene per sempre, come nel caso della famiglia di Pietro De Bastiani di Cergnai di Santa Giustina che nel 1887 si imbarcò con altre 32 persone, tra le quali figli, nuore e nipoti; a Pietro la triste sorte di non vedere mai il Brasile, essendo morto durante la traversata (e per questo gettato in mare). Drammatica anche la partenza di un gruppo di undici famiglie della zona di Fastro di Arsié guidate dal parroco don Domenico Munari che, imbarcatisi a Bordeaux, subirono un avventuroso naufragio e dovettero fare ritorno in Francia per ripartire più tardi tra mille difficoltà.
Arrivati al porto di Santos, gli emigranti che sceglievano il Rio Grande do Sul venivano imbarcati in mezzi più piccoli per giungere a Porto Alegre; a partire dal 1883 entrò in funzione la Hospedaria de Imigrantes sulla Ilha das Flores, dove gli emigranti dovevano fermarsi per una specie di quarantena. In precedenza erano invece attive le famigerate baraccopoli, luoghi piuttosto squallidi e igienicamente inadeguati dove solitamente il capofamiglia lasciava la moglie e i figli in attesa che lui trovasse un lotto adatto alla sua famiglia. Il governo brasiliano concedeva all’emigrante la possibilità di riscattare il lotto scelto in dieci anni, dopo di che diventava suo per sempre; generalmente gli emigranti provenienti dalla stessa zona si dividevano i lotti, la cui dimensione era vasta perché poteva arrivare anche ai 35 ettari, così da ricreare di fatto dei piccoli paesi dove erano forti le parentele e le amicizie e dove avvennero anche i primi matrimoni, sempre tra compaesani. Le prime generazioni di emigranti diedero vita a famiglie molto numerose, così da creare forza lavoro molto utile nei campi: quando si sposavano i figli rimanevano per qualche tempo in casa con i genitori, fino a quando potevano permettersi un lotto proprio e dare vita ad una altrettanto numerosa famiglia. Solitamente era l’ultimo figlio ad ereditare la colonia, con una compensazione per gli altri eredi maschi e la dote per le figlie femmine. Tutti contribuivano al benessere della famiglia, anche accettando lavori pubblici stipendiati dallo stato; era il padre ad esercitare l’autorità e gestire proprietà e denaro; alla donna competeva il lavoro in casa, la cura della prole e, se possibile, l’aiuto nei campi. Istruzione e catechesi dei figli erano aspetti molti importanti per i nostri emigranti che eressero fin da subito cappelle e piccole aule adatte sia per la scuola, sia per ritrovarsi per pregare. In mancanza di sacerdoti, in ogni comunità vi era un leader religioso, una sorta di prete laico che conduceva le preghiere, guidava i funerali, portava l’Eucarestia agli ammaliati, oltre ad essere sagrestano e fabbriciere. Per conciliare malintesi e conflitti riguardanti la vita sociale erano presenti delle figure che potremmo assimilare ai giudici di pace, ruolo spesso assunto da un emigrante con i giusti requisiti, come il longaronese Giovanni Damian ad Urussanga.
I prodotti che hanno caratterizzato di più la vita nelle colonie bellunesi e venete in generale furono il frumento, la vite e il mais: nessuno di loro fu introdotto dai nostri emigranti, in quanto ci avevano già pensato secoli prima i Gesuiti. Tra questi merita una menzione speciale la vite e quindi il vino, prodotto inizialmente per il consumo proprio e poi per la commercializzazione: generazioni di viticoltori hanno continuato questa attività, come i discendenti di Domenico Rech di Col dei Boffat in Valle di Seren del Grappa, che ancora oggi gestiscono la rinomata azienda vitivinicola Rech di Flores da Cunha.
I bellunesi che scelsero di partire definitivamente per il Brasile scapparono dalla fame e con la speranza di dare migliori opportunità per i propri figli. Per la maggior parte di loro fu proprio così: trovarono un paese che li accolse e che, pur con difficoltà e iniziale sofferenza, diede loro finalmente una terra propria, da loro poi sfruttata al meglio per il proprio futuro. Le prime generazioni di bellunesi continuarono a lavorare i campi permettendo però ai figli di studiare e di ricoprire poi posti di assoluto rilievo nella vita sociale.
L’emigrazione bellunese in Brasile ha segnato la storia delle nostre comunità e continua a farlo, se si considera che il numero dei discendenti bellunesi in Brasile è pari al doppio dei residenti in provincia, una disparità che tenderà ad aumentare, visto il decremento demografico che purtroppo noi stiamo vivendo.





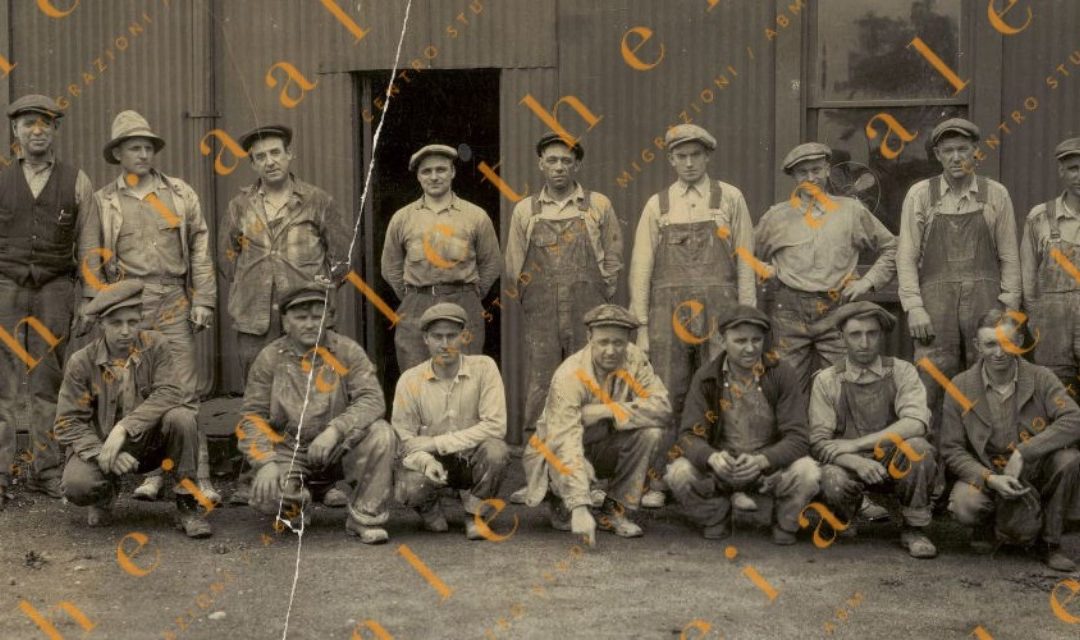
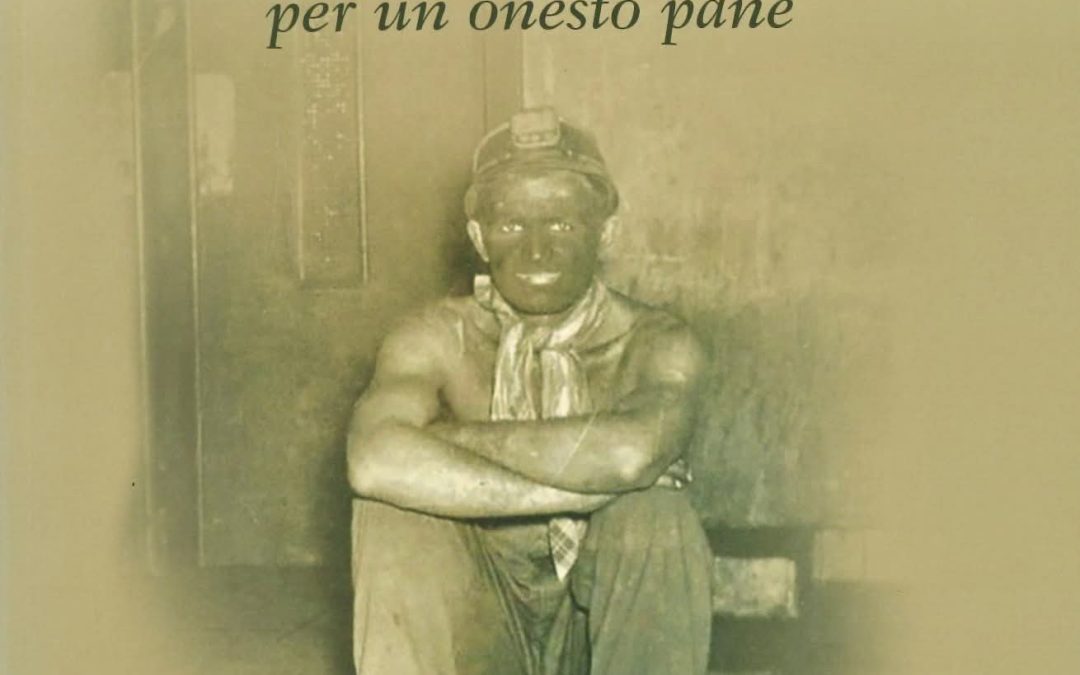
0 commenti