Diecimila lire, qualcosa in meno in caso di gruppi numerosi, qualcosa di più in periodi di vigilanza intensificata, per farsi accompagnare attraverso il confine con la Francia. Da clandestini, ovviamente. Accadeva nell’immediato secondo dopoguerra, quando dall’Italia, secondo un’inchiesta realizzata dalla Società Umanitaria di Milano1, nel periodo tra aprile e agosto si spostavano oltralpe circa tre-quattromila irregolari al mese. Per alcuni degli aspiranti il progetto falliva sul nascere, stroncato dalla polizia di frontiera italiana. Per altri che riuscivano a portare a termine l’impresa, arrivava il rimpatrio da parte degli agenti francesi, anche se – rilevava l’analisi – sia per la «disponibilità assolutamente limitata di personale» deputato alle verifiche, sia per una sua «apprezzabile umanità» nel «chiudere un occhio», così come per le innumerevoli vie «che meriterebbero la sorveglianza» – il numero dei fermati dalla polizia francese era molto limitato rispetto a quello di coloro che riuscivano a sfuggire ai controlli.
Quasi impossibile il buon esito dell’espatrio tramite ferrovia o attraverso i normali collegamenti stradali, la maggioranza dei passaggi avveniva lungo i valichi alpini: per il Piccolo San Bernardo, la Val di Rhêmes, la Valgrisenche o «addirittura passando per il ghiacciaio del Rutor», ma soprattutto nella zona della Val di Susa, da dove transitavano circa i due terzi del flusso migratorio. Decine di ore di cammino (mai «meno di una nottata di faticosa marcia») in condizioni di pericolo spesso sottovalutato per arrivare dall’altra parte, quando qualcosa non andava storto. Gli esiti di questi tragitti, infatti, erano talvolta drammatici, se non addirittura tragici. Lo studio riferisce di due giovani «amputati degli arti per assideramento sui passi della Val di Susa». E ancora: «Il sindaco di Bardonecchia ha visto spirare un giovane emigrante, per denutrizione e per il freddo patito».
Oltre che nel periodo primaverile ed estivo, il rapporto indicava la frequenza di espatri clandestini anche in inverno, in questo caso nella zona di Ventimiglia, da dove i passaggi avvenivano «sia per via di terra che per via di mare».
A gestire i transiti erano in quasi tutti i casi figure che l’inchiesta definiva «professionisti dell’emigrazione clandestina»: «individui che già hanno compiute esperienze di passaggio della frontiera, come emigranti, negli anni scorsi (…), e che ora si occupano quasi esclusivamente di questo, e ci vivono». Per incrementare il profitto sulla loro attività, non era raro che oltre al servizio di guida i passeur imponessero agli emigranti di portare con sé nel viaggio carichi di riso da contrabbandare in Francia.
Lo sfruttamento proseguiva anche una volta giunti a destinazione. I nuovi arrivati potevano essere regolarizzati ottenendo un carta ufficiale di lavoro, documento per il quale diventava fondamentale l’interessamento da parte di chi offriva l’impiego. Accadeva sovente, però, che i datori di lavoro approfittassero della precarietà della loro manodopera immigrata sia per evadere contributi sociali e tasse sia per non avere vincoli contrattuali e quindi «imporre salari arbitrari» e «tenere costantemente i malcapitati in una situazione ricattatoria», costringendoli – con la promessa della regolarizzazione – a occupazioni disagevoli e a condizioni di vita «primitive».
Tra i fermati per emigrazione clandestina, non tutti venivano espulsi. L’approfondimento della Società Umanitaria stimava che i rimpatri effettivamente eseguiti dalle autorità francesi rappresentassero circa il sessanta per cento del contingente di coloro che venivano arrestati. In particolare, l’espulsione era condonata a coloro che chiedevano esplicitamente di essere arruolati per il lavoro di fondo nelle miniere, a quanti dimostravano di avere un parente stretto in Francia disposto a sistemarli e a chi dava prova di voler raggiungere il capofamiglia. In alcune circostanze, inoltre, certe categorie di lavoratori ritenute utili per il sistema economico francese erano dispensate dal rimpatrio.
- L’emigrazione clandestina in Francia, pubblicata nel Bollettino quindicinale dell’emigrazione, Anno II, N. 16-17 – 10 settembre 1948. ↩︎





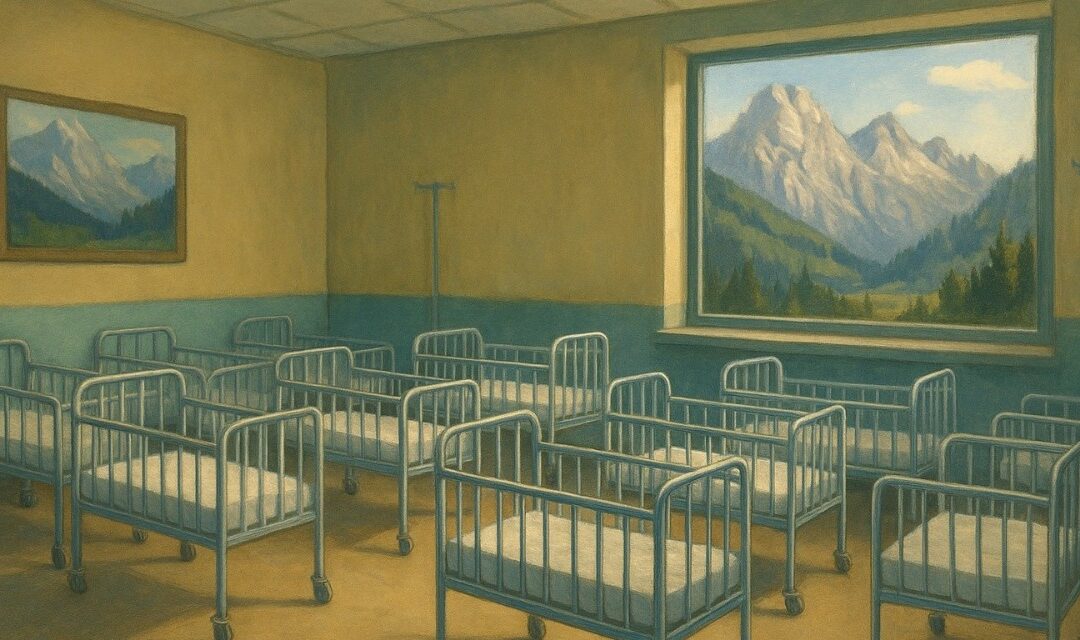
0 commenti